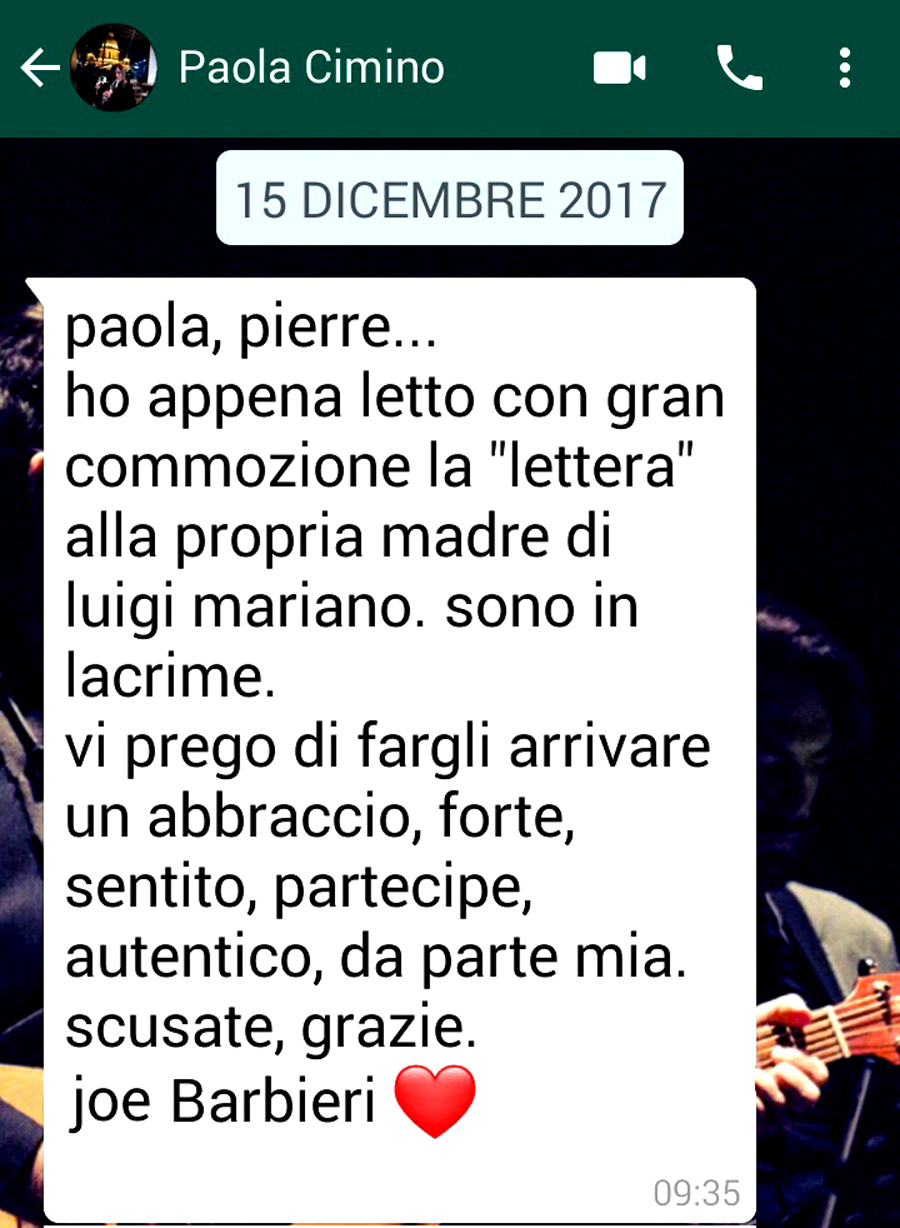“I figli sono come aquiloni,
Passi la vita a cercare
di farli alzare da terra.
Corri e corri con loro
fino a restare tutti e due senza fiato.
Come gli aquiloni finiscono a terra
e tu rappezzi e conforti,
aggiusti e insegni.
Li vedi sollevarsi nel vento e li rassicuri,
presto impareranno a volare.
Infine sono in aria: gli ci vuole più spago
e tu seguiti a darne
e a ogni metro di corda
che sfugge dalla tua mano
il cuore ti si riempie
di gioia e di tristezza insieme.
Giorno dopo giorno
l’aquilone si allontana sempre di più
e tu senti che non passerà molto tempo
prima che quella bella creatura
spezzi il filo che vi unisce e si innalzi,
com’è giusto che sia, libera e sola.
Allora soltanto saprai
di avere assolto il tuo compito”.
(Erma Bombeck)
Mia madre era una ragazza degli anni ’60, ipersensibile, che amava molto l’arte, la musica leggera e la poesia. Soprattutto questa poesia di Erma Bombeck.
L’amava a tal punto che un giorno di vari anni fa la vidi trascriverla a mano, con la sua grafia inconfondibile, e confezionarsi un quadretto semplice, con uno sfondo giallo pastello, che ha tenuto appeso fino alla fine accanto alla porta della sua camera da letto. Diceva sempre di non riuscire mai a leggerla fino in fondo, perché un groppo alla gola le mozzava il fiato dalla commozione.
Aveva l’animo poetico. E, per uno come me, questo è stato una benedizione.
Fin da piccolo mi ha abituato a prestare attenzione a ciò che, nelle canzoni, istintivamente per un bambino arrivava molto dopo la musica, ossia le parole. I bambini assorbono molto la musicalità dei brani, e li cantano, ma il significato di ciò che stanno cantando è spesso a loro oscuro o trascurato, anche dai genitori, che non sempre li indirizzano a rifletterci su. In certi casi il significato di un testo, o di alcune frasi di un brano anche semplice, verrà capito e svelato dopo molti anni, forse addirittura nell’età adulta.
“Bella questa canzone, ma fammi leggere bene le parole” era una frase tipica di mia madre.
Sarebbe stucchevole rimarcare quanto questo sia stato fondamentale nella mia formazione, umana e artistica, con particolare riferimento alla mia attuale attività, che quasi sicuramente non avrebbe forse neanche preso questo preciso indirizzo (cantautore) se non ci fossero state queste premesse.
Per anni (fino alle ultimissime composizioni) mia madre è spesso stata la prima ascoltatrice delle mie nuove canzoni: sia suonatele al piano e sia fattele ascoltare in cuffia, appena provinate. Le amava tutte e ascoltava in macchina sia “Asincrono” che “Canzoni all’angolo”, ma certo aveva le sue preferite: Se ne vanno, Questo tempo che ho, L’ora di andar via, Quello che non serve più. E poi la mai incisa Il ragazzino della casa rosa, che era infastidita del fatto non avessi mai inserito in un disco. Mentre stavo per iniziare a registrare l’ultimo album, mi spiazzò: “Cerca di inserire anche brani rock: funzionerà di più”. Restai di sasso: da lei, la romanticona amante delle melodie e delle ballatone, non mi aspettavo quel suggerimento, che mi diede forza. Lei sapeva che, dopo quello che avevamo vissuto per papà, c’era bisogno di una sterzata per risalire. E credo mi stimolasse su questa strada. Oltre a Stefano Mannucci, Alberto Lombardi e Pierre Ruiz, dunque mia madre è la quarta persona a cui devo il filone più rock di quasi metà del nuovo disco.
Per via di mio nonno, maresciallo della Marina, la mamma aveva trascorso tutta l’adolescenza nel quartiere del Casale, a Brindisi (lo stesso di Tony Bungaro, al quale ho spesso raccontato di questa felice coincidenza) e non nella sua Nardò, che vedeva solo d’estate. Questo la portava a sentirsi di Brindisi e a considerarla a tutti gli effetti la sua città: ci aveva passato gli anni più spensierati della vita ed erano nate le amicizie più forti.
Da sempre, tutte le volte che vado a Brindisi e mi avvicino al mare, mi commuovo.
Rivedo gli anni ’50-’60, rivedo una ragazza ipersensibile che cresceva tra mille paure, ma con la pulizia negli occhi e mille progetti semplici e veri nella testa.
Molto dell’esistenza della famiglia d’origine di mia madre fu purtroppo condizionato da un fatto tragico dovuto alla guerra, che non tutti conoscono ma che, dopo quasi ottant’anni, credo si possa rivelare.
Era l’8 novembre 1941 e di notte gli inglesi sganciarono una pioggia di bombe su Brindisi. Ne cadde anche una dentro al giardino di mia nonna, incinta di tre mesi del suo primogenito Vittorio. Lo spavento causò una forte ischemia del feto. Il mio amato zio Vittorio, ossia colui che quand’ero bambino mi avrebbe comunque insegnato (a metà anni ‘80) i primi rudimenti di pentagramma, sarebbe poi nato, nel 1942, con una lieve disabilità, sufficiente però a impedirgli di vivere come avrebbe voluto, gettando nello sconforto il carattere già severo e ansioso di mia nonna e ponendo le basi per una futura malinconica cupezza familiare, cui le due figlie venute dopo (mia madre e poi la zia Laura), ipersensibili, certo non furono indifferenti, assorbendo fin da piccole l’urgenza di prendersi un po’ cura del fratello maggiore più sfortunato. E così hanno poi fatto davvero, entrambe, per tutta la loro vita.
La grande amarezza di mia nonna rispetto alla sfortuna avuta dal suo primogenito, che non poteva concretamente soddisfare tutte le sue aspettative di donna ambiziosa, volitiva e orgogliosa, si tramutò in gioia allo stato puro quando nacque il primo nipote: io. La mia venuta al mondo nel 1973, quando ormai era vedova da pochi anni, fu una luce, agì nella mente di mia nonna come rivitalizzante, si sentì ringiovanita e rinata: ora c’era un altro “figlio” maschio da accudire e a cui rivolgere le attenzioni. E stavolta (forse!) quel piccolo dono del Cielo avrebbe anche potuto darle le soddisfazioni che invano tanto aveva desiderato e cercato in passato.
Le caratteristiche più evidenti della personalità di mia madre, oltre all’ipersensibilità e a un senso innato del perdono, erano la fragilità e la forza, perfettamente alternate e complementari. Cadeva nel fondo del fondo, a volte. Ma a un certo punto, una bella mattina di sole, apriva le finestre dopo una notte insonne e si rialzava sempre, reinventandosi un entusiasmo nuovo e voltando completamente pagina. E pareva incredibile che appena poco tempo prima avesse sofferto così tanto.
Era una maestra elementare, poi passata all’asilo per cause di forza maggiore: l’opportunità (da cogliere al volo) di poter lavorare nel paese in cui s’era accasata poco tempo dopo il matrimonio, Galàtone. Non ha mai pensato di dover fare solo la casalinga, sia perché voleva una sicurezza economica e sia per una sua gratificazione personale e sociale. Quindi (come ragazza degli anni ‘60) era comunque avanti rispetto a tante altre ragazze del sud. Quando nascemmo io e mio fratello, riuscì a conciliare nel migliore dei modi il doppio ruolo di lavoratrice e di madre, dando successivamente fiducia a me bambino e responsabilizzandomi (da primogenito) in piccole cose quotidiane, che facevano crescere. Per la befana arrivavano i doni più belli e, negli anni ’80, ad ogni settembre si partiva in auto verso le mete del centro nord, vivendo viaggi indimenticabili.
Ogni estate la mia famiglia prendeva in affitto un villino di campagna, in cui ci raggiungeva anche mia nonna con lo zio Vittorio. E questo ha reso molto speciali i ricordi d’infanzia.
A sette anni ricevetti in dono una bicicletta arancione e, poco tempo dopo, anche i primi libri d’avventura di Verne e Salgari. Era sempre lei che lanciava questi stimoli. A 14 anni mia madre intuì una mia potenziale passione futura, quella per i gialli, e mi regalò “Assassinio sull’Orient-Express” di Agatha Christie. Mi piacque così tanto che nel giro di due anni comprai una quarantina di “Poirot” e li prestai anche a cari amici, che ancora mi ringraziano. Da quello stimolo poi mi spostai da solo a Poe, Chesterton, fino a Umberto Eco con “Il nome della rosa”, romanzo storico e assai colto, mascherato da giallo.
Scegliere la Facoltà di Medicina, nel ’92, non significava solo dare seguito a un’attitudine personale di ragazzo particolarmente brillante negli studi, né solo emulare il percorso e l’esempio dell’idolo Enzo Jannacci, o di due cari zii paterni e di tre cugini materni (tutti medici). C’era dell’altro. Voleva anche dire fornire a mia nonna, e di riflesso a mia madre, l’opportunità di un simbolico riscatto: personale, familiare e sociale. Fin da subito avevano puntato tutto su di me, riempiendomi di attenzioni esagerate, che io tra l’altro non ho mai cercato e che mi hanno sempre molto imbarazzato, sia in generale e sia rispetto agli altri nipoti, anche perché ho sempre avuto un carattere schivo, riservato e abbastanza timido. Sia mia madre che mia nonna mi amavano immensamente, ma avevano sofferto molto: mia nonna per la storia legata a mio zio Vittorio e anche per via della vedovanza; mia madre per i gravissimi guai economici arrivati nell’azienda di mio padre, in quegli anni, che la obbligarono (da dipendente statale) a tamponare buchi giganteschi per salvare la famiglia dai debiti societari. I miei grandi risultati negli studi davano molta gioia, sia a mia madre che a mia nonna. E offrivano loro una ragione quotidiana per vivere ed essere felici, nonostante le amarezze profonde vissute. Tutto questo non poteva non attecchire, in modo del tutto inconscio e forse un po’ malato, nel mio animo grato. E indurmi a cercare un modo per rendere felice chi mi voleva bene, soprattutto rispetto ai frequenti apprezzamenti, espressi senza sosta, sulla rispettabilità e dignità della professione medica.
Sono queste le radici umane, comprensibili, di alcune scelte di vita compiute a 19 anni e fatte più per “restituire amore” che per una reale, profondissima autoanalisi su sé stessi riguardo desideri, aspirazioni e percorsi. Il problema è che tutto questo “donarsi solo alla famiglia e ai suoi desideri reconditi” può a volte essere fonte di eventuali disastri intimi, soprattutto se un bel giorno (mentre si studia con diligente e ferrea disciplina, conseguendo anche risultati eccellenti) ci si scopre in realtà infelici, a lungo, per anni, senza capire bene il perché. O soprattutto se, nel frattempo, si intuisce che si è nati per fare ben altro. E che solo la musica e le canzoni sanno farti far pace coi tuoi demoni.
La verità è che l’amore sacro per la propria famiglia non dovrebbe mai essere tale da annientare e mettere completamente da parte quello per sé stessi. Io ho commesso questo peccato. E stavo rischiando di perdermi.
“Dov’è l’errore nel tuo passato?
Cos’è che uccide come un peccato?”
Un bel giorno capisci che, per trovare l’errore nel tuo passato, occorre risalire indietro, forse fino a quelle bombe su Brindisi del 1941. E senti che tutto questo ancora riecheggia ed esplode, come una nemesi, attraverso mille bombe atomiche che precipitano dentro il tuo stomaco. E poi in una canzone, a distanza di 75 anni.
Mia madre, per motivi legati al suo carattere, ha capito (molto prima di mio padre) che la musica era la mia vita. E, pur molto delusa dalla mia decisione radicale riguardante gli studi, ha via via molto amato il mio percorso artistico, parlandone con orgoglio (cosa che mio padre non faceva) con chiunque le capitasse a tiro.
Ha sempre letto ogni singola recensione, ha voluto sapere ogni dettaglio riguardo i premi vinti o i concerti meglio riusciti. Alcuni riconoscimenti (tipo il “Premio Civilia Salento”) li ho dedicati a lei, presente in prima fila agli spettacoli. Così come ho dedicato a lei il mio primo disco, “Asincrono”. Non dimentichiamo che fu lei nel 1991 a regalarmi la prima tastiera, a sorpresa, per Natale. E a regalarmi un pianoforte a muro nel 2009.
Ma c’era un’altra cosa che le scrissi e le dedicai, di cui era fiera e commossa.
Era gennaio 2004, io mi trovavo a Roma, in piena crisi universitaria, cosa che le nascondevo per non farla preoccupare. Lei continuava ad incoraggiarmi con cura amorevole, nonostante avessimo in passato avuto un po’ di scontri. Allora mi nacque una filastrocca quasi infantile, perché volevo dar voce al bimbo che lei aveva cresciuto e che stava per prendere decisioni molto forti, virando in modo deciso verso la musica.
Mia madre ha un bel dono
sempre pronto da offrire
e un festoso richiamo
per un abbraccio d’amore
che si apre mai illuso
di raggiungere il mare
le basta un sorriso
e un tenue raggio di sole.
Mia madre ha cascate
d’ingenua freschezza
e cento diamanti
d’inusitata bellezza
sono specchi di luce
nei sentieri scoscesi
che donano pace
ai viandanti indifesi.
Mia madre ha preghiere
sgorganti dal petto
che volan leggere
attraverso il soffitto
in cerca di un segno
per un grazie verace
come puro bisogno
di sentire una Voce.
Mia madre ha speranze
traboccanti dal cuore
di accorciare distanze
di una vita migliore
di oleandri e di ortensie
e profumi d’amore
di colori e fragranze
e di petali in fiore.
Mia madre è distrutta
ma trova tempo per gli altri
e anche se ha fretta
ha imparato a fermarsi
con che slancio e calore
sa riaccendere un fuoco
restituendo vigore
a chi s’abbatte per poco.
Mia madre ha ferite
riportate in battaglia
e memorie intristite
appese dietro le ciglia
la sua anima grande
mi saluta dal suolo
lei li immagina liberi
gli aquiloni nel cielo.
Suona strano dirlo, ma a persone che amavano in modo così totalizzante come mia madre risultava quasi impossibile immaginare che un figlio potesse amare con lo stesso grado di intensità. Questa poesiola ruppe ogni sua convinzione. E si sentì “ufficialmente” amata, davvero amata, come madre. Per me è stata però anche sorella maggiore e figlia. Ho perso tre persone in una.
Successivamente, nel 2012, arrivò la malattia inguaribile della zia Laura e poi nel 2013, a ruota e senza respiro, quella di papà. Anni terribili. In meno di un anno, la mamma perdette le due colonne della sua vita, i due pilastri essenziali, le due figure familiari di riferimento assoluto.
Furono per lei momenti di dolore e sconforto. Stavolta rialzarsi appariva un po’ più difficile.
Quando, dopo un anno, capì di essere anche lei malata, ebbe un vero momento di abbattimento e sembrava volesse lasciarsi andare, non curarsi nemmeno, quasi a voler raggiungere quanto prima la sorella e il marito.
Mi accorsi di questo suo strazio e a novembre 2015 decisi che avrei fatto di tutto per cercare di porvi rimedio. Un giorno pensai di aver trovato la chiave: responsabilizzarla col fratello Vittorio e coi figli. Mi ricordai di una struggente poesia di Pier Paolo Pasolini, pubblicata nel 1964 e rivolta alla madre. Una supplica di continuare a voler vivere, di non voler morire, di farlo anche per lui, figlio.
Gliela stampai e gliela lasciai di notte sul tavolo della cucina. Andai a dormire più sereno.
La poesia era questa.
“È difficile dire con parole di figlio
ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio
tu sei la sola al mondo che sa,
del mio cuore, ciò che è stato sempre,
prima d’ogni altro amore.
Per questo devo dirti
ciò ch’è orrendo conoscere:
è dentro la tua grazia
che nasce la mia angoscia.
Sei insostituibile. Per questo è dannata
alla solitudine la vita che mi hai data.
E non voglio essere solo. Ho un’infinita fame
d’amore, dell’amore di corpi senza anima.
Perché l’anima è in te, sei tu,
ma tu sei mia madre
e il tuo amore è la mia schiavitù.
Ho passato l’infanzia
schiavo di questo senso alto,
irrimediabile, di un impegno immenso.
Era l’unico modo per sentire la vita
l’unica tinta, l’unica forma: ora è finita.
Sopravviviamo: ed è la confusione
di una vita rinata fuori dalla ragione.
Ti supplico, ah, ti supplico:
non voler morire.
Sono qui, solo, con te,
in un futuro aprile…“
L’indomani trovai un biglietto della mamma, scritto a mano, che custodisco gelosamente.
Era rivolto a me. È quello che ho letto in chiesa al suo funerale, l’8 dicembre.
“Ciao Luigi Filippo,
ho letto Supplica a mia madre di Pasolini cento volte e per cento volte ho pianto.
Ho riflettuto sul grande amore di un figlio verso sua madre, perché quello della madre verso il figlio è scontato. È la più bella cosa che io abbia mai letto, insieme alle tue, ed ho cercato analogie con te.
Forse ci sono… e mi sono un po’ alleggerito il cuore.
Ho pensato al dolore che avrai quando non ci sarò più ed ho sofferto.
Adesso però voglio vivere: per te, per Riccardo e anche per mio fratello Vittorio, perché so che potrete ancora avere bisogno di me. Mi curerò, stai tranquillo. E cercherò di superare, senza lamentarmi, tutti gli ostacoli che incontrerò. Voglio vederti felice”.
tua madre Giuliana
13 novembre 2015
________________________________________
La lettera dei 70 anni a noi figli e il testamento morale (luglio 2016)